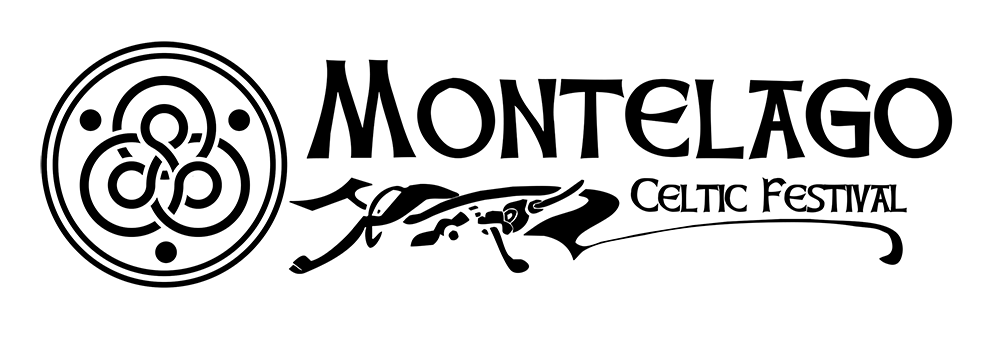Tra pochi giorni si festeggerà la Pasqua di Resurrezione cristiana, ed è questo il momento migliore per parlare di alcune piante associate, nell’immaginario popolare, alla Passione di Cristo. Da secoli ed in moltissime culture ricorrono dei simbolismi vegetali legati alla crocefissione di Gesù, come la corona di spine e l’albero al quale si impiccò Giuda Iscariota, tanto che ogni luogo ha le sue superstizioni al riguardo, ma anche delle specie arboree identificate, di volta in volta, con queste credenze.
Il Sambuco (Sambucus nigra), è un comune arbusto molto ramificato, che raggiunge altezze dai 2 ai 5 metri e presenta dei piccoli fiori color crema ad inizio estate, grappoli di bacche color vino scuro da settembre in poi. Un suo parente stretto, il sambuco rosso (Sambucus racemosa), chiamato anche “sambuco a grappoli” o “ebbio” (dal latino ebulum), più piccolo, gli somiglia molto, ma le sue bacche sono scarlatte. È una specie montana, diffusa fin nel nord della Cina, mentre il sambuco nero non va più in là dell’Asia minore. “Una volta, nelle campagne, dalle bacche del sambuco si traeva una tintura e anche un liquore che doveva essere poco apprezzato, dato che la parola hièble, ebbio, ‐ gnole in borgognone – sarebbe all’origine dell’argot gnôle, che indica un’acquavite di cattiva qualità” (Brosse; 1987). Il colore intenso e scuro della bacca del sambuco rosso o ebbio, “detto anche sambuco selvatico, sambuco femmina” (Beccaria; 1995), sembrerebbe che abbia originato denominazioni popolari per l’arbusto, come jávëlë a Foggia e diavularu a Catanzaro; Beccaria precisa che, a meno che non si tratti di una vicinanza fonica, il termine veneto géolo, il calabrese e lucano jévulu, ‐a, e jébbëlë a Castel del Monte (L’Aquila) non hanno nulla a che fare col diavolo, ma discendono direttamente dal latino ebulum, ebbio, come mostrano anche i toponimi calabresi Jévoli e
monte Evoli (Beccaria; 1995).

La pianta era nota nella medicina popolare grazie alle proprietà sudorifere dei fiori e purganti dei frutti, mentre le foglie venivano usate nella cura ai reumatismi ed all’idropisia. Le proprietà del sambuco nero erano già state descritte da Plinio il Vecchio nella “Naturalis historia”; In Tirolo, il sambuco era chiamato “medicina degli dèi” in quanto la medicina tradizionale tirolese ricavava rimedi utili dai germogli, dai fiori, dalle foglie, dai frutti, dal midollo, dalla corteccia e dalle radici (Polia; 2010). “Dove passa il sambuco, non passa né medico né chirurgo” recitava un proverbio ligure, e nell’Agordino centrale “el sambúch el sana tut”.
Nelle tradizioni popolari era ritenuta una pianta dotata di poteri particolari: in Friuli la si considerava erba quasi sacra, che non si doveva distruggere perché difendeva dal fulmine, nel Biellese i fiori raccolti la notte di San Giovanni tenevano lontana la grandine (Beccaria; 1995). Il fiore del sambuco aveva la fama di guarire tutte le malattie; la parte interna della scorza era purgativa ed usata contro l’idropisia, i fiori sudoriferi, la radice emetica, i fiori ed i frutti diuretici, i fiori in infuso impiegati per combattere il catarro. In Cadore si usa l’infuso delle foglie del sambuco come lassativo; la marmellata dei frutti cura la tosse; i fiori essiccati e fatti rinvenire in acqua, posti sul ventre, calmano i dolori mestruali; con i fiori freschi si ottiene un vino effervescente e molto gradevole (Polia; 2010). L’antropologo Mario Polia ha documentato un particolare uso apotropaico del sambuco in Umbria, a Venza di Cerreto; “Il sambuco che, inseminato dagli uccelli, cresce nelle cavità di certi alberi, specie del salice, era detto “legno stregone”. Le donne incinte usavano portarne un pezzetto addosso, senza separarsene mai, fino al giorno del parto poiché credevano che il “legno stregone” le proteggesse efficacemente dal pericolo dell’aborto” (Polia; 2010).

Raccontano che, davanti al sambuco, ci si doveva togliere il cappello ed inchinarsi (Beccaria; 1995). Fino agli inizi del Novecento, i contadini tedeschi, quando si trovavano al cospetto di un albero di sambuco, si cavavano di testa il cappello. I contadini tirolesi s’inchinavano per sette volte dinanzi al sambuco in omaggio alla virtù curativa contenuta nelle sette parti della pianta: radici, corteccia, midollo, frutti, foglie, fiori e germogli (Polia; 2009).
In Tirolo, Bretagna, Russia e Danimarca “si usava piantare sambuchi tutt’attorno alla casa per proteggerla dalle stregonerie” (Cattabiani; 1998). In Tirolo si piantavano alberi di sambuco intorno ai masi di montagna ed alle case per proteggere gli abitanti ed il bestiame dalle serpi e dai malefici (Polia; 2010). In Bretagna lo si mischiava nella lettiera, per la capacità di allontanare serpenti, salamandre e rospi dalle stalle (Beccaria; 1995). Nella Bretagna settentrionale il sambuco proteggeva dai malefici le case presso le quali era piantato e ne teneva lontani i serpenti. Nel XVII secolo gli stregoni temevano come la morte di essere battuti con un bastone di sambuco. In Danimarca l’arbusto era considerato il protettore di tutta la famiglia, in Russia si riteneva che cacciasse gli spiriti maligni (Brosse; 1987).
Brosse definisce il sambuco come una pianta dal passato glorioso, sulla base dei suoi due nomi greci, actea o actè e dendrôdès. Actè designava infatti il “nutrimento di Demetra”, cioè il grano, ed è probabilmente derivato dall’antico radicale indoeuropeo che ha dato il sanscrito açnati, “mangiare”, il che fa supporre che le bacche del sambuco siano state un alimento per gli uomini dell’età dell’oro, che non conoscevano i cereali e traevano nutrimento dagli alberi. Sappiamo peraltro che i frutti del sambuco venivano raccolti e consumati dalle popolazioni neolitiche. Quanto a dendrôdès, significa “della natura degli alberi”, ma si riferiva soprattutto alle loro ninfe, in particolare alle Amadriadi della quercia. È quindi verosimile che in un passato assai remoto il sambuco fosse considerato un dono degli dèi, se non divino lui stesso (Brosse; 1987). In Abruzzo, a Caramanico e Celano, il sambuco che nasce sulla quercia (caso rarissimo), si serba, “ed è la mano di Dio contro le streghe” (Finamore; 1981).
Il termine sambucus designava anche un piccolo flauto, fatto con un ramoscello di sambuco vuotato nel midollo. Il “flauto magico” delle leggende germaniche era di sambuco; i suoni che se ne traevano proteggevano dai sortilegi. Nel folclore dei diversi popoli europei il sambuco è sempre stato usato a questo scopo; lo testimoniano certi nomi locali dell’arbusto, sambuce e hautbois, oboe. Quanto a sureau, sambuco, in francese antico si scriveva seü, dal latino sabucus, e deve la sua forma attuale alla contaminazione con l’aggettivo sur, “acido, asprigno”, per il gusto delle sue bacche (Beccaria; 1995).

Tra i germani, il sambuco era detto Holunder, sacro a Frau Holda, o Hulda/Holda, entità sovrannaturale che viveva tra i rami del sambuco, specie di quelli che crescono in prossimità di acque salubri (Polia; 2009). Nei Grigioni si credeva che tra i rami di sambuco dimorasse una divinità benefica, probabilmente una fata dai lunghi capelli biondi, come la germanica Frau Holda, che appare sotto forma di una bella ragazza dai capelli biondi avvolta in un candido manto, allegoria del manto nevoso che copre il bosco nel mese di dicembre, quando avviene la sua epifania. Sul Renon, invece, si credeva che tra i rami di sambuco si nascondessero le streghe (Polia; 2010). Oltre ad essere la divinità tutelare del sambuco, Frau Holde, o Holda, è anche patrona dell’arte del filato, delle nascite e degli animali domestici, ma “è anche signora delle streghe (ed in questa funzione si sovrappone a Diana) e delle notturne scorribande di spettri montati su cavalli neri, conosciute come “Caccia Selvaggia” prendendo, questa volta, il posto e spesso anche il nome in prestito da Odino/Wođan” (Polia; 2010).
Come spesso succede, i poteri del sambuco erano ambigui, quindi, come teneva lontani i demoni, poteva anche attirarli. Alcune leggende raccontano che per evocare il diavolo si deve salire su una pianta di sambuco; altre ancora che tagliare il sambuco causa la morte o altri mali: il diavolo, infatti, si diceva dimorasse tra le sue radici (Beccaria; 1995). Nel folclore inglese bruciare il sambuco “porta il diavolo in casa”. Un sermonario francese del XIII° secolo s’indigna contro le sciagurate donne che portavano i figli presso i sambuchi demoniaci, e rendevano loro omaggio con doni ed offerte (Brosse; 1987). Anche nelle nostre zone è probabile che, verso la fine del Medioevo, il sambuco fosse oggetto di particolari riti, come farebbero supporre certe rampogne lanciate da san Giacomo della Marca contro coloro che “adorano il sambuco” (Polia; 2009). Nel XIV° secolo l’inglese William Langland, nel suo “Piers the Plowman”, menziona una credenza contadina secondo cui Giuda si sarebbe impiccato ad un sambuco; da allora l’albero divenne oggetto di esecrazione. Le sue bacche, un tempo ottime, dicevano nella Bretagna settentrionale, “sono diventate così amare che non si possono più mangiare”. Sembra che il forte odore dei fiori e delle foglie del sambuco provocasse malesseri che potevano portare alla morte. Questo potere nefasto era forse in rapporto col fatto che il sambuco contrassegnava, nel Calendario degli alberi, il tredicesimo mese lunare, a meno che non sia il contrario, e che il sambuco e Giuda abbiano reso malefica la cifra tredici (Brosse; 1987).
Da questa associazione tra il sambuco e l’apostolo si hanno le denominazioni dell’albero in francese (arbre de Judas), in olandese (Judasboom), in inglese (Judas tree o anche Devil’s wood). Il nome “diavolo” era riferito egualmente a piante dotate di virtù, velenose o curative (Beccaria; 1995).

Per questa sua valenza negativa, in molte delle nostre zone si evita di bruciare il legno di sambuco nel focolare domestico. In Valnerina le motivazioni addotte per spiegare questo tabù sono diverse: “a Poggioprimocaso dicevano che “non poteva essere bruciato perché portava scalogna”. A Sciedi non poteva essere bruciato perché il sambuco era l’albero della Madonna, così dicevano i vecchi senza sapere perché lo si chiamasse in tal modo, e se lo si bruciava faceva male alla testa; “adesso non ce se fa più osservazione”. A Trivio dicevano che se si fosse bruciato in casa il legno del sambuco sarebbe morto il capofamiglia. La nonna di un’anziana di Trognano evitava persino di portare in casa il sambuco: “il sammoco no’ lo riportava mai dentro casa”. A Villa San Silvestro e a Poggio Bustone, nel Reatino, si credeva che se si fosse bruciato il sambuco nel focolare, le galline non avrebbero più fatto le uova (“non fetavano più”). A Rocchetta di Cerreto ci dissero che non poteva essere arso in casa perché “c’ha l’animo dentro” e bruciarlo è peccato. A Cortigno di Norcia si ritiene che il fumo del sambuco bruciato sul focolare domestico faccia ammalare gli animali. A San Marco di Norcia si evitava di bruciare in casa il legno di sambuco perché si credeva che inducesse una sorta d’insana sonnolenza” (Polia; 2010). Occorre, inoltre, menzionare il divieto che, nel Cerretano, proibiva di bastonare le bestie mediante rami di sambuco, o col legno della vite (Polia; 2009).
In Abruzzo la tradizione vietava di bruciare nel focolare domestico il legno del sambuco perché, secondo una vecchia tradizione, Giuda si sarebbe impiccato proprio a quell’albero (Finamore; 1981). Per quel che riguarda gli usi pratici del legno, di quello del sambuco non se ne faceva molto. Un detto diceva: “Mejo lu sammucu là ‘ll’ortu che lu pérsicu a la vigna”, a significare che le cose utili e buone, come gli alberi di pesco, quando stanno lontano dalla vista possono essere preda dell’altrui cupidigia mentre il sambuco da nessuno era concupito (Polia; 2009).
Diversi sono, nelle tradizioni popolari, i tipi di albero al quale Giuda si sarebbe impiccato; si tratta comunque spesso di alberi dai rami gracili, fico, sambuco, tamerice. In Ucraina si dice che le foglie del pioppo tremulo sono continuamente agitate dal vento dal giorno in cui Giuda si è impiccato ai suoi rami (De Gubernatis; 1878). In genere, il nome di albero di Giuda è riservato in tutta Europa al Cercis siliquastrum, che nei dialetti italiani svaria nei tipi albero del diavolo, albero maledetto, legno maledetto, ed anche albero della Madonna, fior di Maria; albero d’amore in Toscana; in Calabria, albero di Giuda era il nome della Tamarix gallica, in Sicilia della Tamarix africana che, secondo la leggenda, era un albero grande e splendido, maledetto da Dio dopo che Giuda si appese ad un suo ramo; diventò allora un cespuglio brutto ed inutilizzabile, tant’è vero che non si può neppure accendere il fuoco con il suo legno (Beccaria; 1995). Stessa fama ebbe il fico, maledetto nei Vangeli: nel Comasco viene riportata una testimonianza dell’inchiesta napoleonica (1811) sulle tradizioni popolari del Regno Italico, “alcuni si tengono dal mangiar fichi dicendo che quest’albero è maledetto perché vi si è impiccato Giuda” (Tassoni; 1973). Nel Comasco, attesta ancora Tassoni, era vietato alle donne salire sulle piante di fico perché le avrebbe fatte morire. In Toscana albero del diavolo, ovvero ábbiru du diávulo designa un tipo di fico (Ficus religiosa), nome che si riscontra in varie lingue dell’Europa cristiana: “albero del diavolo”, cioè “pagano”, è stato diffuso in Europa dai missionari operanti in India quando seppero che questo era l’albero sacro per eccellenza, adorato dai buddisti, l’albero della chiaroveggenza, della saggezza universale, sotto le cui fronde Buddha era stato illuminato dalla Verità (De Gubernatis; 1878).

Numerose anche sono le piante legate, nell’immaginario popolare, alla corona di spine posta sul capo di Cristo il giorno della sua crocefissione. Una di queste è la Gleditsia triacanthos, un arbusto originario dell’America settentrionale, coltivato nei viali per le siepi, una volta ampiamente utilizzato per la costruzione di recinti destinati al bestiame. La sua altezza va dai 15 ai 30 metri ed è costituito da una moltitudine di rami spinosi, disordinati e tortuosi. L’epiteto triacanthos si riferisce alle tre lunghe ed acuminate spine che costituiscono la ramificazione delle punte, dall’aspetto così letale che ha dato origine alla leggenda secondo la quale, con questi rami spinosi, sia stata intrecciata la corona del Redentore. Per questo la pianta è comunemente nota come spino di Giuda o spino di Cristo, in Piemonte come spina ‘d Nussugnur o spina Cristi, in Emilia Romagna è spîn o boch dal Sgnóur, o ancora ed noster Sgnóur, in Veneto spini del Signore mentre in Sardegna spina de Gristu (Beccaria; 1995).
In Valnerina, nel Cerretano, proprio a causa di questa credenza, ancora oggi si evita accuratamente di bruciare nel focolare domestico il legno di questa pianta (Polia; 2010).
Ci sono poi molti altri tipi di arbusti ed erbe spinose alle quali è stata attribuita la medesima valenza simbolica popolare, ad esempio: spina giudaica, spina crocefissi in Toscana, in Liguria spina de Cristo, in Lombardia spi del Signúr, nel medio Ticino spina dal Signori, spina Cresta (ma anche spino di Giuda), spéine di Criste in Puglia (nel barese pane de Criste, perché le foglie tenere venivano consumate nel periodo pasquale) è il nome della marruca (Paliurus spina‐Christi Miller), arbusto spinoso che forma cespugli impenetrabili, già titolato nell’antichità per l’efficacia contro il morso di serpenti e scorpioni (in francese dialettale épine de Christ, in inglese Christ’s thorn, in tedesco dialettale Christusdorn). Lo spinocervino (Rhamus cathartica), i cui rami vecchi terminano con una spina, in Italia ha nomi popolari e dialettali come spino santo, spino di Cristo, in Sicilia spina di crucifissu (in tedesco dialettale Kreuzbeere, “bacche della croce) perché la tradizione popolare vuole che con queste spine sia stata intrecciata la corona del Figlio di Dio. Il crespino (Berberis vulgaris), arbusto cespuglioso disseminato alla base di ogni di due o tre spine, è in Toscana o in Piemonte spina santa, in Piemonte anche spina ‘d Nostr Sgnur, in Lombardia spina Cristi, spin de cros, in Veneto spin de la passión, spin de la croce, in Friuli spin di cros. Nel Friuli anche il biancospino ed il fermabue (Ononis spinosa) sono chiamati entrambi spini del Signore; in Italia, in tutti i dialetti settentrionali e centrali il Lycium europaeum ha nome spine della croce, del Signore, di Cristo, e anche spino giudeo (in provincia di Ferrara e a Forlì), nell’Alessandrino (Strevi) spelacríst. In Francia l’Ilex aquifolium è detto épine de Christ, in Alsazia Christdorn; l’uva spina (Ribes uvacrispa) è in tedesco dialettale Christusbeere, “bacche di Cristo”, perché era anch’essa titolata per avere intrecciato la santa corona di spine (Beccaria; 1995).
 Foto di Gianluca Carradorini
Foto di Gianluca Carradorini
Sempre in Germania, Judasbeeren (“bacche di Giuda”), sono chiamati i semi della rosa canina, in tedesco dialettale Judendorn, “spina dei giudei”. In Trentino (Val di Sole) il nome tradizionale del frutto della rosa canina era calcavecla (da calcavecchia, denominazione attestata in vari dialetti italiani al fine di esprimere la sensazione fisica del peso molesto nel sonno, di un “colui che calca”, ovvero che si siede col suo peso sul petto del dormiente provocandogli incubi ed angosce); il nome dipende dal fatto che nel corso dei secoli è stata considerata una pianta magica, dai misteriosi poteri (Beccaria; 1995). La denominazione di “rosa canina” deriva dal fatto che si pensava avesse le virtù di guarire dall’idrofobia contratta dal morso dei cani (Beccaria; 1995).
I suoi usi medicinali erano, effettivamente, molteplici: soprattutto il frutto essiccato veniva impiegato come decotto contro la tosse ed il catarro intestinale, i mali di reni e di fegato. Un singolare potere sonnifero era poi attribuito alle galle spugnose della rosa, quella caratteristica escrescenza dovuta ad un parassita, che sembra un piccolo nido di uccello, una specie di spugna lanosa. Prima di coricarsi era d’uso popolare mettere sotto il guanciale questo pomo del sonno (in tedesco dialettale Schlafsapfel), che faceva dormire profondamente per via del sonnifero contenuto, opera delle streghe. In ceco si chiama spánek (da spáti, “dormire”). Il nome latino saccus palearis, o saccupalea, “sacco di paglia”, dipende certamente dall’usanza di collocare questa galla della rosa canina sotto il pagliericcio per conciliare il sonno; nel Teramano la rosa canina è detta pagliónica; in Sardegna ninnieri, da ninniare, “cullare, addormentare i bambini con la ninna nanna”. In Belgio un nome popolare della galla della rosa canina è guanciale di Cristo, in Germania cuscino della Madonna, in Francia mela o barba del buon Dio. Il fiore aveva un potere particolare: era ritenuto un sicuro rimedio contro gli incubi. Una sua denominazione friulana è garofano della strega o barás (rovo) di strie (Udine), in Valtellina pappa de stria, in Francia masco, rose sorciére, rose au diable.
 Rosa canina fiorita, sullo sfondo il Pizzo del diavolo, Monti Sibillini
Rosa canina fiorita, sullo sfondo il Pizzo del diavolo, Monti Sibillini
Il simbolismo della rosa canina e, soprattutto, del suo fiore, è strettamente legato alla Passione e al sangue del Cristo e, dunque, alla salvezza propiziata dal sacrificio del Figlio di Dio. Nella simbologia cristiana la rosa selvatica, con i suoi cinque petali, è l’immagine delle cinque piaghe del Redentore ed è l’equivalente della coppa che raccolse il sangue di Cristo (Polia; 2010). Nella “Vitis Mystica” si legge che ogni goccia di sangue del Crocefisso forma un petalo della rosa della Passione. La rosa selvatica, inoltre, si presta bene ad incarnare il simbolo della rinascita e del rinnovamento primaverile, simbologia che la lega all’evento di Resurrezione celebrato dalla Pasqua cristiana.
Sebbene sia quasi del tutto sbiadito, in Umbria rimane ancora qualche sporadico ricordo della relazione tra la rosa canina e la corona di spine, come ad esempio nel Monteleonese, dove era proibito bruciare nel focolare domestico il legno della scarvèlla perché, secondo la leggenda narrata dai più anziani, la corona di Gesù sarebbe stata intrecciata usando proprio i rami di rosa canina. A Trivio ed a Trognano si credeva, senza conoscerne il motivo, che bruciare la scarvèlla nel camino mettesse in pericolo la vita del capofamiglia (Polia; 2010).
La rosa canina aveva, però, diversi usi tra la gente dell’Umbria: coi frutti della schiavarella si preparavano tisane curative. Col legno, liberato dalle spine, si costruivano cerchi usati per appendervi i salumi. Un tempo, le ragazze più povere, ad imitazione delle costose collane di corallo, infilavano i frutti della rosa canina a mo’ di grani di collana. A parte la qualità del materiale, rimaneva l’effetto apotropaico del colore rosso (Polia; 2009).

Un’altra tradizione della Valnerina legata alla Passione proibiva di tagliare i bastoni dall’arbusto della “sanguinella”, perché da quella pianta sarebbero state tratte le verghe con cui i soldati picchiarono Gesù.
All’origine dell’associazione della pianta con la Passione il colore rosso dei rami ed il nome vernacolare, ma dovette esistere anche un mito primordiale, oggi obliato, che raccontava come il colore del sangue del Redentore si fosse trasferito alla sanguinella (Polia; 2010). La Cornus sanguinea, della famiglia delle Cornacee, è una pianta tipica dei boschetti, siepi e brughiere, specie su suoli calcarei; appare come un arbusto cespuglioso ed arriva fino a 4 metri di altezza. Come insito nel nome la pianta, sanguinea che deriva da sanguis, sangue, la caratteristica principale dell’arbusto risiede nel colore scarlatto dei rami giovani, simile a quello del sangue rappreso. All’approssimarsi dell’inverno le foglie assumono un colore rosso-violaceo. Fiorisce con fiori bianchi da aprile a giugno e, dove il clima lo permette, ancora a settembre. I frutti drupacei della sanguinella sono neri ed il loro sapore è amaro. Plinio la chiama “uirga sanguinea: bastone di sangue” e riferisce l’uso di usare la parte interna della corteccia per far riaprire le ferite chiuse malamente; Virgilio usa “uirga rubea: bastone rosso”. Macrobio, nel passo citato, la chiama semplicemente “sanguis” e l’annovera tra le piante infelices, consacrate agli dèi degli inferi: i numi che non ascoltano le suppliche e volgono altrove il capo (Polia; 2010). Altri nomi con cui è nota la sanguinella, o sanguinello, nella tradizione popolare sono sangue del Signore, oppure stuoie del diavolo, bacche del diavolo, uva della serpe (Beccaria; 1995).
 Rosa canina e Monte Vettore
Rosa canina e Monte Vettore
Grazie a queste tradizioni e credenze popolari legate al concetto di religione e contestualizzate al ceto rurale di un tempo, possiamo indagare con curiosità il concetto di “religiosità” popolare come un fattore che regolava le precarie esistenze dei nostri antenati: “dinanzi alle spietate condizioni del presente e all’incertezza del futuro, esposto senza difese all’arbitrio dei cicli meteorologici e alle calamità naturali, il contadino‐allevatore vedeva nella religione il metodo che gli assicurava il controllo di ciò che, altrimenti, sarebbe divenuto inspiegabile” (Polia; 2010).
Bibliografia
G. L. Beccaria, “I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e le parole perdute”, Einaudi, Torino, 1995
J. Brosse, “Storie e leggende degli alberi”, Edizioni Studio Tesi, 2020, ristampa del 1987
A. Cattabiani, “Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante”, Mondadori, Milano, 1998
A. De Gubernatis, “La mitologia delle piante ovvero le leggende del regno vegetale”, MIR Edizioni, Mosca, 2010, ristampa del 1878
G. Finamore, “Tradizioni popolari abruzzesi”, Edikronos, Palermo, 1981
M. Polia, “Tra cielo e terra. Religione e magia nel mondo rurale della Valnerina” vol. II “Tematiche del pensiero religioso e magico”, Edicit, Foligno, 2009
M. Polia, “Le piante e il sacro. La percezione della natura nel mondo rurale della Valnerina”, Quater, Foligno, 2010
G. Tassoni, “Arti e tradizioni popolari. Le inchieste napoleoniche sui costumi e le tradizioni nel Regno Italico” in “Arte e monumenti della Lombardia prealpina” vol. IX, Bellinzona, 1973
Immagini dell’autore e prese dal web
Xilografie di Wolfgang Meyerpeck su tavole di Giorgio Liberale in “Commentarii in sex libros Pedacii Discordis Anazarbei de materia medica” di Pietro Andrea Mattioli